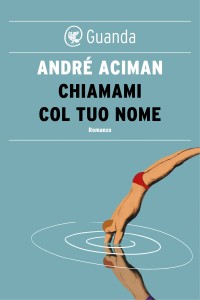Chiamami col tuo nome (2017), di Luca Guadagnino, immagine del manifesto| Video trailer a fondo pagina
Che l’amore sia un mistero era noto già all’anonimo autore di quello scandaloso e delicato idillio pastorale, composto, alla maniera di Teocrito, nella Giudea del V-III secolo a.C. e poi, riletto, reinterpretato, sublimato all’uopo, divenuto sacro all’ebraismo col nome di shìr hasshirìim e al cristianesimo antico con quello di Cantico dei Cantici o di Cantico sublime. “Bianco e rosso è l’amato mio, uno stendardo su moltitudini, la sua testa è oro puro, un mare d’onde, come corvi neri i suoi capelli, come colombe nei corsi d’acqua i suoi occhi si bagnano nel latte, abitano nell’opulenza, le sue guance sono aiuole di balsamo, giardini pensili profumati, rose molli di resinosa mirra le labbra sue, lamine d’oro incrostate di brillanti le sue mani, un avorio splendente tempestato di zaffiri è il suo ventre, colonne di marmo bianco le sue gambe, su basi di oro puro. Appare come il Libano, sublime come i cedri.” Se qualcuno ha pensato, in passato, che il Cantico sia il racconto mascherato di uno struggente desiderio omoerotico, innegabile è che nei suoi versi e nei suoi profumi il desiderio, vissuto drammaticamente nella sua dimensione più carnale e allo stesso tempo sublimato nella trasfigurazione del sogno, si cristallizza come esperienza universale del pieno e del vuoto, di cui pure Platone pensava che Eros fosse figlio, traendone perciò la natura di filosofo. “Chiamami col tuo nome”, l’ultimo film di Luca Guadagnino, è una fiaba sul desiderio, sul suo pieno e il suo vuoto, ambientata in una calda estate lombarda degli incipienti anni Ottanta, tra le ville e i casali della campagna di Crema, in cui la famiglia italo-ebraica del dotto antichista Perlam accoglie in casa, come ogni anno, uno studente post-doc, ebreo del New England, Oliver (Armie Hammer), per una vacanza di studio e ricerca.
Oliver colpisce tutti per la sua bellezza e per la sua cultura, disquisisce con disinvoltura dell’etimologia latina, poi bizantina, poi araba della parola “albicocco” – la precoce Prunus Armeniaca, simbolo del desiderio sensuale, introdotta in Europa dai Romani – legge e commenta frammenti di Eraclito, cataloga con Perlman bronzi di Prassitele che inducono irrimediabilmente, nelle loro innaturali torsioni, a farsi desiderare. Come un Ganimede, come un Antinoo, come un Tadzio, anche Elio (Timothée Chalamet), il diciassettenne figlio di Perlman, énfant prodige nella turris eburnea della sua famiglia borghese, suona Bach e legge tantissimo. Tra i due si insinua, lentissimamente, tortuosamente, il desiderio, imboccando strade strette ed equivoche, negazioni, dispetti, avvicinamenti, torsioni, ripensamenti. “L’ho cercato e non l’ho trovato” dice dell’amato la Sulamita del Cantico.
Nei raffinati, rarefatti ambienti della settecentesca Villa Albergoni in cui gran parte del film si svolge, curati appositamente dalla designer Violante Visconti di Modrone (nipote del celebre regista Luchino) – la vecchia soffitta in cui Elio scopre il sesso sulle note di Radio Varsavia di Franco Battiato, il salotto pieno di antichi cimeli in cui provoca Oliver a colpi di variazioni di Bach, le grandi e austere stanze in cui i due si cercano e si osservano, le antiche piscine di pietra in cui si fermano a leggere e fingere di ignorarsi – è il vuoto, il terribile vuoto che sempre si riconnette al desiderio, a manifestarsi nella sua tremenda verità. Lo stesso vuoto del “Cantico”, in fondo, qui reinterpretato dalla voce angelica ed esotica di Sufjan Stevens in “Mystery of Love”, main theme del film. “Il Cantico è vuoto. Non contiene niente. Non significa niente. Niente al di là della lettera. – come ebbe a scrivere Ceronetti – In verità, il vuoto del Cantico è lì per confermarne la sacralità. Tutto quello che è vuoto, il vacuum lucreziano, una fossa, una stanza, una carcassa, uno scatolino, è una parte del Grande Mistero, significa attesa di qualcuno o presenza occulta. Il Cantico è un pezzo di vuoto sacrale”. Quando le albicocche sono mature sui rami e la natura esplode rigogliosa, l’amore è svuotamento, emorragia, espropriazione. E appropriarsi, simbolicamente, dell’altro – “Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò col mio”, strappandogli quanto di più intimo e distintivo egli abbia, appunto, nel nome – è una preghiera, sussurrata nel buio, per esorcizzare quel vuoto, fingere di vincerlo, di poterlo vincere.

Da sin. Mr. Perlman (Michael Stuhlbarg), Elio (Timothée Chalamet) e Oliver (Armie Hammer) in una scena del film
Non è solo una fiaba omoerotica, ma una metafora assoluta del desiderio, quella che Guadagnino ci consegna in una pellicola che è anche una fotografia, forse nostalgica e parenetica, del tempo che è stato, della sua grazia e della sua capacità di trasmettere antica saggezza, antica bellezza, come quella delle antichissime statue fatte riemergere al largo del Lago di Garda e poi accarezzate con delicatezza, in segno quasi di venerazione. Un tempo, un luogo capaci di non urlare le cose, ma assaporarle, sentirle, come un frutto maturo. Anche questo, forse, è un modo di esorcizzare il vuoto, nelle parole del professor Perlman: “Rinunciamo a tanto di noi per guarire più in fretta del dovuto, che finiamo in bancarotta a trent’anni, e ogni volta che ricominciamo con una persona nuova abbiamo meno da offrire. Ma non provare niente per non rischiare di provare qualcosa…che spreco!”.

Luca Guadagnino alla Berlinale 2017 – Ph. Elena Ringo | ccby4.0
Centocinquanta nomination raccolte in vari festival di cinema indipendente e ai Golden Globe (3 nomination), 50 premi già vinti e, infine, quattro nomination agli Oscar per questa ultima prova cinematografica del regista di origini palermitane, nelle sale italiane dal 25 gennaio 2018: miglior film, miglior canzone originale (Sufjan Stevens), miglior sceneggiatura non originale (James Ivory) e miglior attore per il giovane franco-statunitense Timothée Chalamet, protagonista della pellicola e sul set, parrebbe, del prossimo film di Woody Allen. E mentre il film, dopo l’anteprima mondiale al Sundance Film Festival e alla Berlinale del 2017, riceveva un generale apprezzamento della critica fino ad essere scelto dal National Board of Review e dall’American Film Institute come uno dei 10 migliori film dell’anno, in Italia divampava la polemica perché, si sa, nemo propheta in patria: a Guadagnino non sembra essere mai stato perdonato il suo Melissa P. dal mondo della cinematografia italiana con cui, del resto, collabora molto di rado o non collabora affatto, come recentemente ha ricordato alla stampa. L’esilio dorato del regista in Italia, dove pure continua a vivere, alternandosi tra Crema e Milano, e dove sta lavorando a un remake, già oggetto di polemiche, del celebre “Suspiria” di Dario Argento, è continuato anche ad anni di distanza dall’esordio e malgrado il successo intercontinentale dei suoi documentari “Inconscio Italiano” (2011) e “Bertolucci on Bertolucci” (2012) e dei primi due capitoli – “Io sono l’amore” (2009) e “A Bigger Splash” (2015) – di quella trilogia del desiderio che trova forse in “Chiamami col tuo nome” il suo epilogo, pure accolto con tiepidità, quando non con aperta ostilità, dai salotti della cinematografia nostrana.
Il film, del resto, ha fatto la sua comparsa in Italia con molto ritardo rispetto ad altri paesi europei e arrivando come in sordina, per una precisa scelta di marketing, che ha tentato in un primo momento di non far emergere chiaramente da trailer e altri materiali pubblicitari l’oggetto omoerotico della storia. Ma la possibilità dell’Oscar potrebbe, si maligna sui social network, indurre molti alla facile tentazione di saltare a conti fatti sul carro dorato del trionfo e celebrarne i fasti in lode di una creatività italiana che del resto non ambiva al prestigioso riconoscimento dal lontano 1999, dai tempi, cioè, de “La vita è bella” di Roberto Benigni. Sarà difficile per molti, d’altra parte, prendere Guadagnino ad autentico simbolo italiota: “Call me by my name” – come il suo regista, nato a Palermo da madre algerina e padre siciliano e poi vissuto in Etiopia fino all’adolescenza, e come l’autore del romanzo da cui il film prende le mosse, André Aciman, statunitense d’adozione ma nato e cresciuto ad Alessandria d’Egitto in una famiglia ebraico-sefardita di origine turca – è un promettente mosaico cosmopolita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CHIAMAMI COL TUO NOME – TRAILER
 Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto
Fame di Sud Il sud Italia come non lo avete mai visto